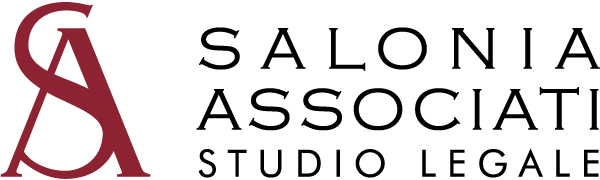La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25729 del 15 novembre 2013, ha statuito che, nei casi di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non può essere in re ipsa, ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro particolare rilievo la prova per presunzioni. Nello specifico, secondo la Suprema Corte, il giudice può trarre il proprio convincimento dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti dal lavoratore, quali – ad esempio – “le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità (all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro) dell’operata dequalificazione”, ovvero dalle conseguenze che possono scaturire da tale condotta, quale “la frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto”. Nella specie, i giudici di legittimità hanno affermato che la dequalificazione del lavoratore, avvenuta senza il suo consenso, comporta un risarcimento pari al 50% della retribuzione lorda per tutto il periodo di demansionamento e ristoro della lesione alla salute e alla perdita di chance.
- English
- Italiano